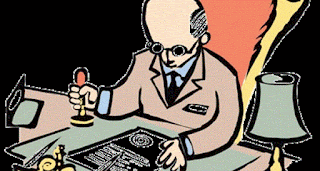Autonomia e rendicontazione: cosa fare per non
“perdere” il Pnrr
Il mondo della scuola sta per essere interessato da una serie di interventi
e investimenti. Ecco quali sono priorità e strumenti più utili al rinnovamento.
Il premier Draghi nel suo recente
intervento agli studenti dell’Its “Caracciolo” di Bari ha affermato che “dalla
formazione non dipende solo il vostro futuro, ma quello di tutti noi. Le
società più prospere sono quelle che preparano meglio i loro giovani a gestire
i cambiamenti”. Il sistema formativo sta per essere investito da una serie di
investimenti e interventi. Che è giusto aspettarsi dal Pnrr nel campo
dell’istruzione? Che ruolo possono e debbono giocare i dirigenti scolastici? Ne
abbiamo parlato con Ezio Delfino, presidente
dell’associazione di presidi DiSAL.
Come affrontare oggi le complessità del
sistema scolastico?
Lo si fa realizzando ambienti formativi
che introducano gli studenti alla “provocazione” insita nella complessità,
offrendo loro un metodo che li abiliti ad essere preparati e resilienti. Si
tratta poi di ricomprendere che la transizione può avvenire solo con il
coinvolgimento di tutta la comunità che ruota attorno alla vita delle scuole:
studenti, docenti, dirigenti scolastici e genitori, reti e istituzioni.
Quali
sono le aree di investimento di cui necessitano oggi le scuole italiane?
L’investimento
sull’autonomia è lo strumento privilegiato per sviluppare
strategie di rinnovamento. È poi prioritaria la manutenzione della qualità
dell’insegnamento, anche attraverso la definizione di un efficace modello di
selezione e formazione iniziale e in servizio dei docenti e di percorsi che ne
favoriscano una carriera interna. Sarà sempre più decisivo progettare metodologie
didattiche elaborate da team di insegnanti impegnati in una forte reciproca
collaborazione e capaci di ideare ambienti mirati ad apprendimenti
personalizzati. Determinante, infine, è la necessità di riallineare la domanda
e l’offerta di competenze, soprattutto per le professioni a elevata
specializzazione.
Quali
priorità deve perseguire prossimamente il sistema dell’istruzione per
allinearsi agli obiettivi dell’Agenda 2030 in materia di sostenibilità?
La
priorità sono: la qualità degli apprendimenti, con attenzione specifica alla
diffusione tra tutti i giovani di competenze per l’occupabilità e per la vita;
il contenimento della dispersione scolastica; l’attenzione all’inclusione;
l’apprendimento permanente per tutti, anche in risposta all’evoluzione
demografica; il sostegno e il potenziamento dell’educazione civica e dei temi
ambientali.
Quali
le principali
azioni del Pnrr per le scuole?
Il
Piano prevede sei riforme entro il 2022: tra queste quella degli Its,
dell’orientamento, del reclutamento degli insegnanti e
della riorganizzazione del sistema scolastico. Gli investimenti
riguarderanno soprattutto due ambiti: l’edilizia scolastica e i contenuti
della nuova didattica. Si tratta di 17 miliardi di
investimenti, di cui 5 in arrivo attraverso specifici bandi entro novembre 2021
(3 per asili e scuole dell’infanzia, 400 milioni per la
riqualificazione delle mense, 300 per le palestre, 800 per le
scuole nuove e 500 per la messa in sicurezza degli istituti).
Entro
quanto tempo devono essere varate queste azioni?
Il
rispetto degli impegni è determinante per l’assegnazione dei fondi
europei. È stata istituita una specifica cabina di regia per consentire di fare
il punto sull’attuazione dei singoli progetti di investimento sulla scuola e di
individuare gli ostacoli che possono presentarsi in modo da poter rispettare il
calendario degli impegni.
Il
Pnrr come va concretizzato operativamente per favorire il rilancio del sistema
di istruzione?
È
importante che non sia attuato implementando soluzioni dall’alto, ma secondo
una logica che integri l’aspetto “trasformativo” (in termini di
innovazione/cambiamento) e quello di “rendicontazione”. Occorre inoltre che i
processi di riforma che riguarderanno tutti i settori della Pa siano attuati
secondo una lettura integrata e armonica dei diversi sistemi, dunque anche di
quello scolastico. La realizzazione del Pnrr dovrà, infine, fare attenzione ai
meccanismi di governance e al ruolo delle autonomie regionali e locali – le
nuove forme di sussidiarietà – e cogliere l’opportunità del rilancio delle
autonomie scolastiche.
Quali
sono gli strumenti che il Pnrr dovrà tenere presente, perché funzionali alla
promozione di processi innovativi nelle scuole?
Occorre
promuovere radicali cambiamenti di processo basati sulla rilevazione
sistematica dei risultati raggiunti nell’insegnamento, che permettano continue
correzioni di rotta; sull’introduzione di strumenti tecnologici e innovazioni
organizzative attuati con investimenti a lungo termine; sull’individuazione di
nuovi criteri di selezione, formazione e valorizzazione del merito dei docenti,
che tengano conto dell’obiettivo di promuovere attraverso l’insegnamento
competenze cognitive e non.
La
ricerca e la letteratura attribuiscono all’investimento sulle no cognitive
skills (Ncs) una nuova frontiera sulla quale le scuole dovranno puntare. Quale
è il suo parere in merito?
È
questo un modo nuovo di intendere i processi educativi che tiene conto della
personalità dei ragazzi e punta al pieno sviluppo della loro persona. Occorre
aiutare lo studente a “imparare ad imparare” attraverso una consapevolezza
critica di quanto si vuole insegnare, in un chiaro quadro di riferimento
teorico delle Cs, Ncs e dei loro nessi. Occorre anche potenziare metodi
educativi che valorizzino l’apporto creativo e interattivo degli studenti
durante e fuori dalle lezioni. Decisivo è, poi, superare un approccio
individualista all’insegnamento per un incremento delle interazioni e relazioni
tra docenti, dirigenti scolastici, famiglie, studenti.
Come
il profilo di una dirigenza scolastica può essere all’altezza delle nuove sfide
e degli investimenti previsti?
È
decisiva la promozione di una governance delle scuole che promuova innovazione
e sostenibilità. Occorre che i dirigenti scolastici siano formati e messi nelle
condizioni di esercitare un nuovo profilo professionale le cui aree di
esercizio siano quelle proprie: le modalità formative (progettazione e realizzazione
della didattica); il sistema di monitoraggio delle attività della scuola; la
definizione degli obiettivi, dei loro target e della loro misurazione; la
gestione delle risorse umane e l’esercizio della leadership educativa.
(Marco Tedesco)
Il
Sussidiario
 Scuole
alle prese con il Pnrr.
Scuole
alle prese con il Pnrr.