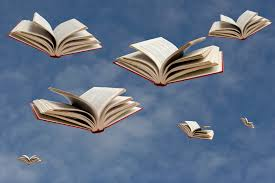Giuseppe legge libri
insieme agli alunni: un susseguirsi di doni e scoperte
e un grazie reciproco.
E
un dono in più: una lettera di Pietro Abelardo
- di Corrado Bagnoli
In tempi di ChatGPT, di dibattiti e di sfide tra intelligenze
vere e virtuali, di emergenze educative che si riaccendono e si aggravano ogni giorno, il mio vecchio amico Giuseppe prosegue imperterrito, anche da pensionato qual è ormai da qualche anno, il suo
mestiere. Il mestiere di leggere ai ragazzi un libro, di chiedere loro di
ragionarci su, di scriverci sopra per scoprire che cosa hanno dentro. Non i
libri, ma loro, i ragazzi. E che non servono programmi e artifici se quel
libro, quel professore ti mette con le spalle al muro e con gli occhi dritti
puntati sul tuo mondo e su quello che hai intorno.
Anche quest’anno Giuseppe
ha finito il suo percorso con le classi seconde. E i ragazzi gli hanno scritto
lettere e-mail sorprendenti. Cose mai viste. Quando stava a scuola e faceva il
professore, era come se ciò che faceva fosse considerato scontato: se sei un
professore di ruolo, svolgi il tuo ruolo. Non si pensava che ci fosse bisogno
di dirsi altro, forse. Quello che contava era quel mestiere di vivere giorno
dopo giorno, crescendo – e per lui invecchiando – insieme; di fare, come
voleva Betocchi nella sua poesia, un’opera comune.
Ma adesso che finito il
libro lui se ne va via e la scuola per i ragazzi continua, adesso legge e
rilegge le mail e non può starsene in silenzio. Io gli ho chiesto di darmi un
ritaglio di quello che si sono scritti – grazie alla scuola, oltre la scuola,
dopo la scuola – lui e i ragazzi. Senza ChatGPT, senza nemmeno correttore
automatico: le lettere degli alunni mostravano con soddisfazione qualche errore
grammaticale o sintattico, ma non era questo che c’era in ballo.
E Giuseppe ha scritto
così ad Alessandro, Francesca, Claudia, Marta, Flavio, Marta, Tommaso,
Sara, Tommaso, Lorenzo, Giulia, Luca, Tommaso, Christian, Elisabetta
Laura, Maria, Christian, Lisa (la gemella buona), Giada, Stefano, Sabrina,
Giulia, Noemi, Elisa, Angelica, Cesare, Giorgio, Francesco, Tomas, Diego e
Alessio, Sofia, Alessio, Jennifer, Mario: “grazie davvero! Come
abbiamo letto insieme, in … dovremmo imparare a dire grazie. Ricominciare a
farlo. E io lo faccio qui, più che commosso per quanto avete scritto nelle
vostre lettere a fine percorso; per quanto avete confessato nei vostri testi
durante l’anno; per come siete stati capaci di lasciarvi interrogare dalle
pagine del libro e dalle mie domande. Qualcuno di voi dice che ha imparato ad
amare la lettura, altri dicono che hanno scoperto il piacere della scrittura;
altri ancora che si sono sentiti parte di un’avventura di crescita e
maturazione in cui non credevano all’inizio. Tutti però ringraziate: me, i
vostri compagni e amici, la vostra insegnante. Tutti ringraziate per la
commozione di alcuni di voi; per le verità che abbiamo scoperto in queste ore;
persino per il divertimento che, nonostante la serietà che vi è stata chiesta,
abbiamo vissuto. È un susseguisi di grazie. E non soltanto nel senso
del dire grazie. È un susseguirsi di doni e scoperte, cioè di
grazie, appunto, quello che è accaduto tra noi: certo ci siamo impegnati,
abbiamo lavorato insieme, ma per me – e anche per voi, come si vede bene dalle
vostre parole – quanto poi è accaduto è sempre molto di più di quanto
uno possa immaginarsi all’inizio pensando a un progetto. Una grazia, quindi.
Sono qui con in tasca ancora le vostre parole, con dentro gli occhi alcuni
gesti capitati tra noi e ho davvero un grande desiderio: quello che questa cosa
possa ripetersi per noi. Nulla è scontato: non sto pensando solo alla proposta
dell’attività anche per l’anno prossimo. Voglio invece che possa riaccadere
sempre questa grandezza, questa bellezza che abbiamo vissuto e provato. Con un
altro libro l’anno prossimo, certo. Ma, ancora di più, ogni giorno in quello
che facciamo e viviamo quotidianamente. Senza smentirmi mai, vi consegno ancora
qualche parola da leggere, un piccolo testo di Pietro Abelardo al figlio Astrolabio, contenuto in
un libricino dal titolo Insegnamenti al figlio. È una paginetta in
cui si parla dell’imparare e dell’insegnare. E ormai l’abbiamo capito tutti:
nessuno insegna, se non impara; spesso anzi impara di più colui che dovrebbe
insegnare. E proprio da quelli che dovrebbero imparare da lui. Così è successo
a me con voi. Eccola, leggetela insieme alla prof. Fateci su qualche pensiero.
E non stanchiamoci mai di dire grazie”.
“Astrolabio, figlio mio,
dolcezza della mia esistenza, ti lascio questo piccolo testamento spirituale,
come insegnamento dell’apprendere e dell’insegnare. Sii teso ad apprendere
più che a insegnare, poiché insegnando sei utile agli altri, ma solo imparando
farai il tuo bene; e non abbandonare lo studio fino a quando non avrai la
certezza di non aver più nulla da apprendere. Subisci il fascino di ciò che è
detto e non di chi lo dice, evitando in tal modo l’accettazione passiva del
sapere, e preoccupati che il tuo docente non ti impedisca di progredire per tuo
conto, tenendoti legato a sé per amore. Come è vero che ci si nutre del frutto
e non delle foglie del melo, così anteponi sempre il significato al
significante e ricorda: la persuasione ha bisogno di catturare gli animi con
discorsi ornati, ma all’insegnamento si addice la chiarezza. Là dove manchi la
ricchezza dei contenuti abbondano le parole; è infatti costume di chi non ha
progetto moltiplicare le strade o sfinirsi in tentativi. Che certezza potrà mai
trasmetterti chi dubita di sé? Solo chi ha una logica di azione resta se
stesso, fermo come il Sole, mentre lo stolto è instabile come l’erratica Luna;
poiché chi ha una mente provvida incede con passo sicuro: prima medita a lungo
e poi parla correttamente, per non doversi giudicare con vergogna. Il desiderio
di comprendere ciò che dicono i dotti e ciò che fanno i buoni arda sempre nel
tuo cuore”.
SCUOLA/ Studenti e prof, la regola "delle cinque A"
per amare la lettura
www.ilsussidiario.it