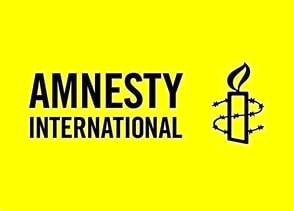di Amnesty
Il Rapporto 2021-2022 di Amnesty International,
pubblicato in Italia da Infinito Edizioni, contiene un’introduzione della
segretaria generale Agnès Callamard, cinque panoramiche regionali e schede su
154 Stati e territori. Tra i temi principali la pandemia di Covid-19, il
razzismo, la lotta alle disuguaglianze e la cura del Creato. Riccardo Noury,
portavoce di Amnesty International Italia: "La mancata equa distribuzione
dei vaccini è un segnale tanto drammatico quanto inequivocabile"
- di Andrea De Angelis - Città del Vaticano
Anche quest’anno, mantenendo una tradizione che va avanti dagli anni Ottanta, Amnesty International Italia pubblica il Rapporto sulla situazione dei diritti umani nel mondo. L’edizione di quest’anno, arricchita da un’introduzione della segretaria generale di Amnesty International Agnès Callamard, contiene cinque panoramiche regionali e schede di approfondimento su 154 Paesi. Oltre al volume, una serie di infografiche presenta le principali tendenze globali. L’edizione 2021-2022 del Rapporto di Amnesty International è a cura di Infinito Edizioni.
Aumentano i conflitti
L'aumento dei conflitti nel mondo è il dato centrale
del nuovo rapporto. Nel 2021 la comunità internazionale non è riuscita ad
affrontare il moltiplicarsi di gravi conflitti che ha generato ulteriori
instabilità e devastazioni di cui milioni di civili nel mondo hanno pagato il
prezzo più alto. Di questa tragica "mappa" fanno parte Afghanistan,
Myanmar, Yemen, Burkina Faso, Libia, Israele e Territori palestinesi, oltre
ovviamente alla Siria. Tra le quattro crisi che maggiormente preoccupano
Amnesty International ci sono i due colpi di stato perpetrati in Asia,
indietreggiata in materia di diritti umani. In Myanmar quasi duemila
manifestanti sono stati uccisi e i conflitti interetnici sono nuovamente
esplosi da quando la giunta militare ha ripreso il potere con un golpe, il
primo febbraio 2021, macchiandosi di crimini contro l'umanità. In Afghanistan
lo scorso agosto i talebani sono tornati al potere e "da allora -
sottolinea Amnesty - è caccia all'uomo e soprattutto alla donna, a chi per 20
anni ha lottato in difesa dei diritti, con blogger, giornalisti, attivisti
inseriti nella lista nera: un vero ritorno al medioevo".
La situazione in Africa
Spostandosi in Africa, Amnesty ha citato la guerra in Etiopia, nel Tigray, la violenza inaudita dei gruppi armati tigrini sulle donne e ragazze della regione Amhara, con il ricorso allo stupro come arma di guerra e vendetta, oltre all'incursione delle forze armate dell'Eritrea e ai 5 milioni di persone affamate senza che gli aiuti riescano a raggiungerle. Guardando all'anno da poco iniziato, l'attenzione è rivolta al Sahel dove la crisi si sta espandendo anche a livello geografico per la minaccia combinata dei gruppi armati jihadisti, la debolezza o l'assenza di Stato e la presenza di forze straniere, in un contesto di siccità e scarso accesso a cibo e vaccini. Per parte dell'Africa c'e' anche da temere una crisi alimentare di grande entità come conseguenza della guerra tra Russia e Ucraina, i due Paesi 'granai' del continente. In questa prospettiva Amnesty teme misure repressive da parte di alcuni governi, Tunisia in primis, per arginare possibili crisi del pane, oltre ad una diffusa carestia e malnutrizione.
Medio Oriente e Bielorussia
In Medio Oriente l'attenzione di Amnesty International
è focalizzata sulla drammatica situazione in Egitto, dove sono 60 mila i
prigionieri di opinione, oltre alla vicenda giudiziaria di Patrick Zaky.
Critiche anche ad Israele, per quella che Amnesty definisce una politica di
espansione degli insediamenti illegali. Particolarmente preoccupante la
situazione dei diritti umani in Iran, dove la detenzione di cittadini europei
viene utilizzata a scopo diplomatico e per trarne altri vantaggi. Iran, Egitto,
Arabia Saudita sono inoltre i Paesi che totalizzano il maggior numero di
condanne a morte. In Europa centro-orientale, Amnesty International ha
deplorato la repressione sempre più dura in atto in Russia ai danni di
oppositori, giornalisti e società civile, ridotta al silenzio. In Bielorussia,
invece, "più che une repressione di stato, siamo di fronte ad un'impresa
criminale" in atto dopo l'elezione contestata di Aleksandr Lukashenko, con
più di mille prigionieri di coscienza. La Bielorussia è accusata da Amnesty
anche per la vicenda dei migranti bloccati al confine con la Polonia in
condizioni disumane e in palese violazione dei diritti umani. "Questa è
stata una delle pagine piu' buie della storia recente dei diritti umani sul
nostro continente" si legge nel rapporto.
L'America Latina
Il Rapporto 2021/2022 di Amnesty International
sottolinea infine come l'America Latina si confermi la regione più pericolosa
del mondo, con ben 252 difensori dei diritti umani uccisi, di cui 138 solo in
Colombia. Oltre la metà, dunque, del totale. In evidenza anche la situazione
del Messico, Paese dove nell'ultimo anno sono stati denunciati oltre mille
femminicidi. Sia Cuba che il Nicaragua sono stati poi teatro di ingenti
proteste represse con violenza e con decine di arresti arbitrari e condanne ad
oppositori.
L'Oms lancia l'allarme sull'equa distribuzione dei
vaccini
"Il 2020 è stato l'anno della disperata ricerca
di una soluzione alla pandemia, trovata nel 2021 grazie ai vaccini, ma gli
Stati ricchi e le grandi aziende farmaceutiche hanno compromesso l'uscita dal
tunnel". Lo afferma Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International
Italia, sottolineando come nei Paesi a basso e medio-basso reddito solo l''8%
della popolazione è stata vaccinata.
"Ancora una volta - prosegue - nel rispondere a
una crisi sanitaria, i profitti sono venuti prima delle vite umane". Una
mancata consapevolezza dell'urgenza di una risposta globale o il prevalere di
interessi economici? "C'è la volontà di far prevalere interessi di parte,
legati alla nazione, lasciando indietro gli altri. Da questo punto di vista il
2021 è stata un'occasione persa e non usciremo dalla pandemia finché i vaccini
non saranno distribuiti in modo equo. L'obiettivo era e rimane questo, ma
risulta essere ancora lontano".
Le discriminazioni razziali
Il 21 marzo si è celebrata la Giornata internazionale
per l’eliminazione della discriminazione razziale. Una ricorrenza che, in tempo
di pandemia e con più di una guerra in corso - l'Ucraina, ma si pensi anche a
Etiopia, Siria e Yemen - assume un significato particolare. Su questa battaglia
di civiltà Amnesty International è stata, anche lo scorso anno, in prima linea.
"Il rischio di considerare questo problema di secondo piano è concreto, lo
registriamo in numerosi Paesi dove ci sono rifugiati meritevoli di protezione
ed altri da allontanare. Proprio la guerra in Ucraina ha dimostrato che un
modello di accoglienza diverso è possibile, ma lo scorso anno non lo abbiamo
visto all'opera". Inoltre "la pandemia ha reso fragili tutta una
serie di diritti, tra questi c'è - sottolinea - anche il superamento della
discriminazione, della violenza fisica e verbale, con un uso eccessivo della
forza verso determinati gruppi".
Nel segno di una ecologia integrale
Lo scorso autunno la cura del Creato è stata al centro
della cronaca internazionale grazie alla Cop26 di Glasgow. Oggi, però, le
questioni ambientali sembrano essere finite di nuove lontane dai riflettori.
"Questo è il problema dei problemi che resterà - ammonisce Noury - anche
quando la pandemia sarà terminata". Nel 2021 sono stati numerosi i drammi
legati ai cambiamenti climatici, "esempio - spiega - di come a pagarne il
prezzo più alto siano coloro che hanno meno colpe". Il pensiero di Noury
va alla siccità che ha interessato un milione e mezzo di persone in Madagascar.
"Glasgow è stata l'ennesima occasione persa per fare qualcosa di
buono", rimarca.
La voce delle popolazioni
Amnesty International sottolinea come siano aumentate
le proteste di massa, nelle piazze così come in rete, delle persone di ogni
continente. Manifestazioni importanti si sono registrate in almeno 80 Paesi.
"Il cambiamento senza una pressione dal basso non arriverà mai, non
possiamo pensare che ci penseranno i governi in modo filantropico o
progressista. Il 2021 è stato un anno di grande attivismo, questo ha fatto la
differenza - conclude - in diversi casi, penso ad esempio a quanto accaduto ed
ancora in corso in Cile. Questo ci dice che senza la partecipazione popolare
continueranno le politiche di esclusione e di egoismo".