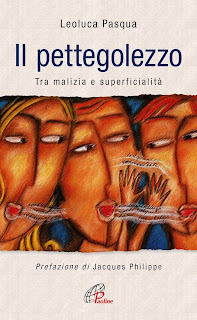L’irreversibilità delle conquiste democratiche e la tentazione «della servitù volontaria»
La paura che ritornino esperienze passate non fa più molta presa. Ma è possibile rinunciare volontariamente alla libertà in cambio di poche concessioni e garanzie?
I cambiamenti culturali, sociali ed economici degli ultimi decenni, soprattutto in seguito alla crisi economica, hanno fatto sì che il tema della democrazia non venga più avvertito come fondamentale Stanno venendo meno tutti gli anticorpi nei confronti dei nuovi possibili pericoli nel segno di un «dispotismo morbido»
di Paolo Nepi *
Ha senso oggi riaprire in Italia la questione del fascismo? Per alcuni la domanda non ha alcun senso, dal momento che anche le forze politiche che a esso si sono per molto tempo richiamate lo giudicano una vicenda irripetibile. Per altri invece ha un senso, non perché si possano riprodurre nuovamente le forme assunte storicamente dal fascismo di Mussolini, ma perché il fascismo costituirebbe una sorta di paradigma politico universale. Legato quindi non alle forme storiche già note, ma a quelle che, in quanto categoria sovrastorica dello spirito umano, può di nuovo assumere. L a questione intorno al fascismo ha avuto in Italia un andamento altalenante. Nel periodo del primo dopoguerra e della guerra fredda il tema del fascismo si collegava a quello dell’antifascismo. Nelle intenzioni degli antifascisti il fascismo costituiva il termine di confronto, ovviamente in negativo, della democrazia e della Costituzione. Sul tema della democrazia, in riferimento all’antifascismo nel secondo dopoguerra, occorre tuttavia una precisazione: poiché nell’antifascismo si riconoscevano in tanti, compresa la totalità della sinistra italiana, egemonizzata dal più forte Partito Comunista dell’occidente, il tema del confronto fascismo/democrazia non si sviluppò in tutta la sua ampiezza nel nostro Paese. E questo per le note ragioni internazionali, dal momento che si era antifascisti per ragioni allora non componibili, dal momento che alcuni si richiamavano alle democrazie liberali e altri al modello sovietico estraneo a questa tradizione politica. Ma soprattutto perché le riconquistate libertà democratiche sembravano definitive e irreversibili.
Negli anni Novanta il tema si è riproposto con la nascita di Alleanza Nazionale, guidata da un leader come Gianfranco Fini, il quale riesce nell’operazione di collocare il partito nell’area del centrodestra, liberandolo della pesante eredità fascista che aveva il Msi. Si trattò di un’operazione politica in gran parte riuscita, che fece uscire dall’isolamento la destra postfascista, portandola non solo al governo degli enti locali ma perfino di quello nazionale. A poco servì a quel tempo la ripresa, peraltro condita più di retorica che di vera analisi politica, dell’antifascismo e del neofascismo come pericolo per la nostra democrazia. otrebbe dunque sembrare una forzatura riaprire oggi la questione del fascismo. Ma lo è veramente? In una conferenza del 1995, Umberto Eco parlò del «fascismo eterno», detto anche «Ur-Fascismo» (Il fascismo eterno, La nave di Teseo). Secondo Eco il fascismo potrebbe sempre riaffacciarsi «in abiti civili» e «sotto le spoglie più innocenti» a tutte le latitudini. Credo che oggi, in un panorama politico che non pone più il problema che poneva la sinistra del primo dopoguerra, il tema del fascismo vada posto in relazione alla evidente crisi della democrazia e delle sue istituzioni.
Le trasformazioni culturali, sociali ed economiche degli ultimi decenni, soprattutto in seguito alla crisi economica scoppiata in P America nel 2008 e propagatasi negli anni successivi anche in Europa, hanno fatto sì che il tema della democrazia non venga più avvertito come fondamentale. I ceti medi più esposti alla crisi, i giovani disoccupati, i pensionati che faticano ad arrivare alla fine del mese, i professori e gli impiegati demotivati, non vedono più nella democrazia un valore politico primario da difendere. Sono ormai lontani, nel ricordo di molti, i lutti e le distruzioni della Seconda guerra mondiale, e le limitazioni alla libertà che tra le due guerre mondiali hanno imposto regimi illiberali e totalitari. La 'paura' del ripetersi di tali esperienze, forse giustamente, non fa più presa. Ma stanno venendo meno tutti gli anticorpi nei confronti di nuovi possibili pericoli per la democrazia, che nessuno è al momento in grado di prevedere con precisione, ma che in un certo senso aleggiano minacciosamente.
«Lo Stato liberale e secolarizzato vive di presupposti che non può garantire. Questo è il grande rischio che lo Stato ha scelto di correre per amore della libertà». Questo teorema, che risale al filosofo del diritto tedesco Wolfgang Böckenförde, ci mette in guardia dal considerare la democrazia un fatto definitivamente acquisito. Ma non tanto la democrazia come insieme di procedure formali che regolano la vita sociale. Böckenförde intende infatti la democrazia come un costume, ovvero come una consuetudine in cui i cittadini si sentono parte di una 'casa comune' affidata alla responsabilità di ciascuno, con compiti diversi ma ugualmente importanti. Ed è qui che si pone appunto la questione del fascismo, inteso come soluzione d’uscita da una crisi generale. Un’uscita che si ripropone come via breve e semplice, una scorciatoia rispetto alle faticose mediazioni che richiede il processo democratico. questo punto non si tratta di individuare i soggetti politici che possono farsi interpreti di questo passaggio involutivo A della nostra democrazia. E non si tratta neanche di vedere in questo o quel capo politico il nuovo 'duce'. Sono infatti più di venti anni che l’Italia, dopo un breve periodo, ha fatto passare, con un movimento inverso a quello di manzoniana memoria, «dall’altare alla polvere» un numero sterminato di leader, da Berlusconi a Renzi, passando per Prodi, D’Alema, Fini, Monti, Letta e altri. Ed è assai probabile che i leader politici dell’attuale momento facciano prima o poi la stessa fine. I n questo clima, si ripropone la questione del fascismo, in termini assolutamente nuovi. Un fascismo che ci rimanda ad alcune acute analisi psicosociali, come la nozione di «servitù volontaria» (De La Boetie) e di «dispotismo morbido» ( Tocqueville). Venute meno le appartenenze di classe, dove la casta (o meglio le caste) costituiscono esclusivamente la tutela di interessi particolari senza nessun vincolo di appartenenza, ci si affida, dice Toqueville, a «un immenso potere tutelare, che si occupa da solo di assicurare ai sudditi il benessere e di vegliare sulle loro sorti. È assoluto, minuzioso, metodico, previdente, e persino mite. Assomiglierebbe alla potestà paterna, se avesse per scopo, come quella, di preparare gli uomini alla virilità. Ma, al contrario, non cerca che di tenerli in un’infanzia perpetua. Lavora volentieri alla felicità dei cittadini ma vuole esserne l’unico agente, l’unico arbitro. Provvede alla loro sicurezza, ai loro bisogni, facilita i loro piaceri, dirige gli affari, le industrie, regola le successioni, divide le eredità: non toglierebbe forse loro anche la forza di vivere e di pensare?». P iù che un fascismo che toglie le libertà, l’«Ur-fascismo» di cui parla Eco sarebbe dunque un fascismo che invita a rinunciare volontariamente alla libertà, in cambio di alcune concessioni e garanzie, come fa il Grande Inquisitore di Dostoevskij nei confronti di Cristo, reo – a suo giudizio – di aver predicato la libertà a un popolo che chiedeva solo pane e giochi in un clima di totale sicurezza.
* Docente di Filosofia morale, Pontificia Università 'Antonianum' Roma
www.avvenire.it