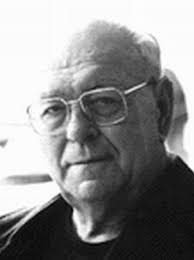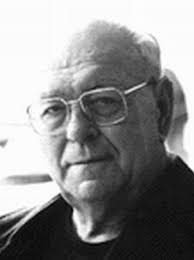
Ricordando
DANILO DOLCI
a cento anni dalla nascita
-
di Italo Bassotto
Strana
facoltà umana è la “memoria”: ci porta a ricordare solo chi vogliamo e a
dimenticare chi ci dà o ha dato fastidio… Tra i tanti “memento” della storia,
noi educatori e pedagogisti abbiamo celebrato il centenario della nascita di
Don Lorenzo Milani, priore di Barbiana e i due lustri dalla morte di Mario
Lodi, il maestro del Po di Piadena: entrambi monumenti e colonne
dell’educazione scolastica democratica e “umana” (nel senso di rispettosa ed
attenta alla dignità dei bambini e dei ragazzi nell’esercizio del loro diritto
allo studio). E, insieme a noi, gente di scuola, si sono accodati nelle
celebrazioni i media nazionali (e non solo), gli opinion leaders e,
naturalmente i politici più attenti e sensibili. Si sono realizzati più di 400
convegni, seminari, giornate di studio per approfondire il pensiero e le opere
dei due “maestri”; molte Università hanno dedicato i corsi monografici dei due
anni accademici recenti alla presentazione delle due figure emblema della
pedagogia contemporanea; sono stati pubblicati non meno di una decina di testi
e centinaia di articoli che approfondivano i diversi aspetti dei metodi
educativi di Don Lorenzo e di Mario Lodi…
Al
contrario dei cento anni dalla nascita di Danilo Dolci, poeta, sociologo,
educatore, sostenitore delle cause dei poveri contadini della Sicilia,
propugnatore del metodo non violento nella politica e nelle rivendicazioni
sociali, antifascista e nemico della mafia nessuno ha fatto cenno: né i media,
né gli epigoni delle lotte per il riscatto dei poveri (contadini, operai,
giovani disoccupati), né tanto meno gli apparati istituzionali della scuola,
dello Stato e della Chiesa si sono mossi per ricordare una persona che ha speso
la sua vita per il riscatto degli ultimi.
Provo
a riassumere la storia della sua vita breve, ma intensa (1924-1997); zingaro
nella sua infanzia e giovinezza (nato in Slovenia, il padre ferroviere
costringe lui e sua madre a vivere in diverse città del Nord) studia a Brescia
e a Milano, manifestando uno straordinario interesse per le arti (musica,
letteratura e pittura), ma anche una forte avversione al fascismo che lo porta
a rifiutare la divisa da repubblichino ed a fuggire nel centro Italia, dove
vive gli ultimi due anni della guerra facendo il pastore in Abruzzo, ospite di
un contadino. Finita la guerra emigra a Roma dove si iscrive ad Architettura,
ma non finisce gli studi perché, tornato a Milano, comincia a frequentare gli
ambienti della rivolta culturale e sociale: le fabbriche di Sesto san Giovanni
ed il ri-nascente movimento operaio; le lezioni di Ernesto Bonaiuti teologo e
filosofo che sostiene le tesi del modernismo e, per questo, sospeso a divinis;
ed infine sceglie di andare a vivere l’esperienza di Nomadelfia, una comune di
cristiani animata da don Zeno Saltini. Dopo due anni, abbandona la comunità e
si trasferisce nella Sicilia occidentale, la più povera e derelitta vivendo fra
Partinico e Trappeto. Qui inizi il suo lavoro di alfabetizzazione e di
sensibilizzazione dei contadini mettendo a punto i due pilastri della sua “filosofia
esistenziale”: il metodo maieutico (o del dialogo sociale e politico con la
povera gente) e la pratica della non violenza (he gli varrà il titolo di
“Gandhi italiano” insieme ad Aldo Capitini). Tre sono le azioni degne di essere
raccontate negli anni della sua testimonianza sociale e politica a favore dei
contadini siciliani: i digiuni (diversi e in diverse contesti) per smuovere i
politici siciliani e nazionali in favore dei poveri da lui protetti (la prima
volta non mangia per giorni adagiato sul letto di un bambino morto di fame);
gli “scioperi alla rovescia”, ovvero invece di non andare a lavorare gli operai
ed i braccianti si riunivano in gruppi con lui che li guidava a svolgere lavori
socialmente utili (come sistemare strade prima impercorribili, edificare dighe
per dare acqua alle campagne, costruire case per i terremotati del Belice che
vivevano in baracche fatiscenti anni dopo quella immane tragedia…
Tutto questo
gli provocò numerose denunce spesso sostenute da notizie di reato ridicole come
quelle che gli vennero mosse per “digiuno pubblico illegale” (sic!), oppure nel
caso degli scioperi alla rovescia di “istigazione a disobbedire alle leggi”
(negli stessi anni al Nord don Mazzolari e don Milani scrivevano che la
disobbedienza era un dovere morale quando le leggi erano ingiuste o contrarie
alla propria coscienza!). Fu processato almeno cinque volte e in due fu anche
condannato al carcere, ma non smise mai di praticare le sue battaglie in favore
degli ultimi con il metodo della non violenza attirando intorno a sé numerosi
giovani, che avevano compreso il senso della sua lotta: ricordo Peppino
Impastato, Lorenzo Barbera e Goffredo Fofi. Intanto anche la sua produzione
letteraria cominciava a dargli notorietà e ad attirare l’attenzione sia degli
intellettuali italiani (Vittorini, Levi, Bobbio, Moravia…) sia europei (Russel,
Sartre, Piaget, Huxely…); vinse numerosi premi ed ottiene riconoscimenti sia in
Italia che all’estero: purtroppo anche in Russia riceve il premio Lenin, che fa
gridare i media italiani al fatto che egli era un pericoloso “comunista” …
Intanto
avvia altre tre straordinarie iniziative: la prima “radio libera” italiana
(Radio Partinico), che viene chiusa dopo meno di 30 ore e lui denunciato,
ovviamente!, la seconda è la creazione del Centro Educativo di Mirto (frazione
di Partinico) nel quale mette a punto i suoi due principi pedagogici: il
dialogo maieutico e la cooperazione scolastica fra gli alunni, partendo dalla
distinzione fra “trasmettere e comunicare”(per quanto riguarda il metodo
dialogico) e il “potere e il dominio” per quanto riguarda la collaborazione…
Infine merita di essere ricordato il suo impegno nella lotta alla mafia con
particolare riguardo alle sue commistioni con la politica specie negli anni che
dal 1970 vanno fino alla sua morte. Questa battaglia gli portò denunce e processi,
ma soprattutto il disprezzo di quella stessa gente che lui cercava di aiutare:
infatti veniva tacciato di denigrare la Sicilia ed i suoi abitanti con questo
suo voler denunciare continuamente il malaffare e la corruzione legata ai
poteri mafiosi, perfino il cardinale Ruffini lo elencava fra i tre malanni che
portavano disprezzo alla Sicilia: il romanzo di Tomasi di Lampedusa (il Gattopardo), il gran parlare di mafia e
Danilo Dolci che, con le sue iniziative e le sue polemiche, gettava il
discredito sulle istituzioni e su ciò che di buono si andava facendo nell’isola.
Negli
ultimi anni di vita il rivoluzionario e animatore sociale lascia il posto al
poeta ed allo scrittore: pubblica una raccolta di poesie (tra le quali c’è la
bellissima: ciascun bambino cresce solo se sognato…) che gli varrà il premio
Viareggio e mette a punto in diversi saggi i pilastri del suo pensiero
educativo e sociologico (il dialogo, la non violenza, la cooperazione) con un
progressivo allargamento ai temi della pace e della convivenza fra i popoli.
Questi lavori, pubblicati dalla fine degli anni ’70 sino alla sua morte, lo
porteranno a ricevere in India il premio Gandhi ed a Bologna la laurea honoris
causa in scienze dell’educazione.
Mi
sono dilungato sui passaggi salienti della biografia di Danilo Dolci, perché il
suo è un caso assai raro nel quale il pensiero si capisce per intero
semplicemente guardando alle azioni ed alle scelte di vita del protagonista.
Caratteristica tipica dei “maestri”, per i quali il pensiero diventa vita e
l’esperienza vissuta riflessione, ma allora mi chiedo (e chiedo ai miei
lettori) come mai Mario Lodi ed il priore di Barbiana suscitano tanta
attenzione sia all’interno della scuola, sia sui mezzi di comunicazione di
massa, mentre, al contrario, Danilo Dolci è caduto nell’oblio quasi totale?
Credo che la spiegazione stia nel fatto che la sua testimonianza pedagogica e
politica abbia avuto come terreno di coltura la Sicilia dei poveri, dei
terremotati, delle vittime delle vessazioni mafiose… e la Sicilia non ha una
buona audience sui media nazionali. Si dimentica così che, in realtà, per
Danilo Dolci la Sicilia non era altro che un “laboratorio” della sua idea di
equità, di giustizia sociale di relazioni istituzionali ed umane ispirate alla
pace ed alla non violenza. Ogni volta che una sua iniziativa saliva agli onori
della cronaca (spesso quella processuale) egli non perdeva l’occasione per far
diventare la vicenda che lo vedeva accusato un prototipo di quello che doveva
essere il messaggio di solidarietà da comunicare (non da trasmettere, come
diceva lui) a tutte le comunità in lotte per uscire dal degrado e dalla
miseria. Ma su questo passaggio era sempre più solo: i suoi amici se ne
andarono prima di lui e le mass comunications non amavano il suo messaggio
silenzioso e non violento.
Per
quanto riguarda il metodo dialogico in educazione oggi c’è una rinascita della
maieutica e della costruzione sociale degli apprendimenti, ma abbiamo dovuto
(da inveterati provinciali) passare attraverso le linee metodologiche elaborate
nel mondo anglosassone (l’intelligenza emotiva, la flipped classroom, il
debate, la philosophy for children…), dimenticando che in Europa le cose che
dicono questi autori le facevano già Socrate Platone e Aristotele 400 anni
prima di Cristo!